La “Compensatio lucri cum damno” a seguito delle sentenze Cass. SS.UU. nn. 12564-12565-12566-12567/2018
Novembre 5, 2019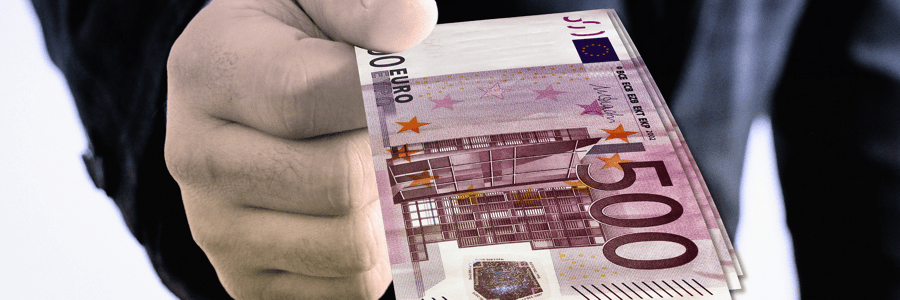
In ambito assicurativo, il principio della “compensatio lucri cum damno” costituisce un corollario del principio indennitario, secondo cui la garanzia assicurativa non deve risolversi in un indebito arricchimento dell’Assicurato.
Tale principio trova la sua primaria fonte normativa nell’art. 1905 del Codice Civile, secondo cui le assicurazioni contro i danni hanno esclusivamente la funzione di reintegrare il patrimonio dell’Assicurato – o di terzi, nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile – nei limiti del danno subito in conseguenza del verificarsi del sinistro.
La natura indennitaria delle assicurazioni contro i danni pone pertanto un limite al risarcimento, ulteriore rispetto alle delimitazioni, qualitative e quantitative, contenute nelle clausole contrattuali.
Esplicazioni di tale principio sono contenute – tra gli altri – negli artt. 1908 (valore della cosa assicurata), 1909 (assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) e 1910 (assicurazione presso diversi assicuratori).
La “compensatio lucri cum damno” ha pertanto la funzione di assicurare la detraibilità dall’importo dovuto quale risarcimento dall’autore dell’illecito di altri benefici ricevuti dal danneggiato in forza di altre tipologie di obbligazioni.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i criteri ai quali fare riferimento per valutare la legittimità di tale detraibilità sono sostanzialmente due:
- l’accertamento del nesso causale tra illecito e beneficio percepito dal danneggiato con conseguente valutazione della ragione giustificatrice di tale beneficio,
- la previsione legislativa di un meccanismo di surroga o di rivalsa.
In applicazione di tali criteri, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta a dirimere quattro differenti fattispecie processuali.
In particolare, la Corte ha ritenuto applicabile la compensatio in tre casi, ovvero:
- tra risarcimento da fatto illecito corrisposto dal terzo responsabile ed indennizzo dovuto in forza di assicurazione contro i danni;
- tra risarcimento da fatto illecito corrisposto dal terzo responsabile e rendita per inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per infortunio in itinere del lavoratore;
- tra risarcimento da fatto illecito consistente nel danno patrimoniale futuro per assistenza al danneggiato ed indennità di accompagnamento corrisposta allo stesso dall’INPS.
In un solo caso la Corte ha ritenuto non sussistere la compensatio, e cioè tra risarcimento da fatto illecito consistente nel danno patrimoniale riflesso patito dal congiunto della vittima e valore capitale della pensione di reversibilità corrisposta dall’INPS al congiunto stesso.
La ratio di tali pronunce è da rinvenirsi – in primis – nella sussistenza o meno della connessione eziologica tra risarcimento ed ulteriore beneficio percepito dal danneggiato: nel caso in cui entrambi siano conseguenze dirette ed immediate del medesimo fatto ed abbiano la medesima funzione si procede allo scomputo; se, viceversa, il beneficio trova solo la sua fonte occasionale nell’illecito, come avviene nel caso di diritti successori o di pensione di risarcibilità, è ammesso il cumulo con il risarcimento ottenuto dal terzo responsabile.
Una volta accertata l’identità del nesso eziologico, per aversi compensatio è altresì necessario verificare che sussista – in astratto – la possibilità per il terzo datore del beneficio di agire in surrogazione o rivalsa nei confronti del terzo responsabile: ciò al fine di evitare che l’autore dell’illecito che non abbia ancora risarcito il danneggiato possa trarre vantaggio dalla compensatio come, ad esempio, nel caso in cui il danneggiato sia già stato indennizzato dal proprio assicuratore.




